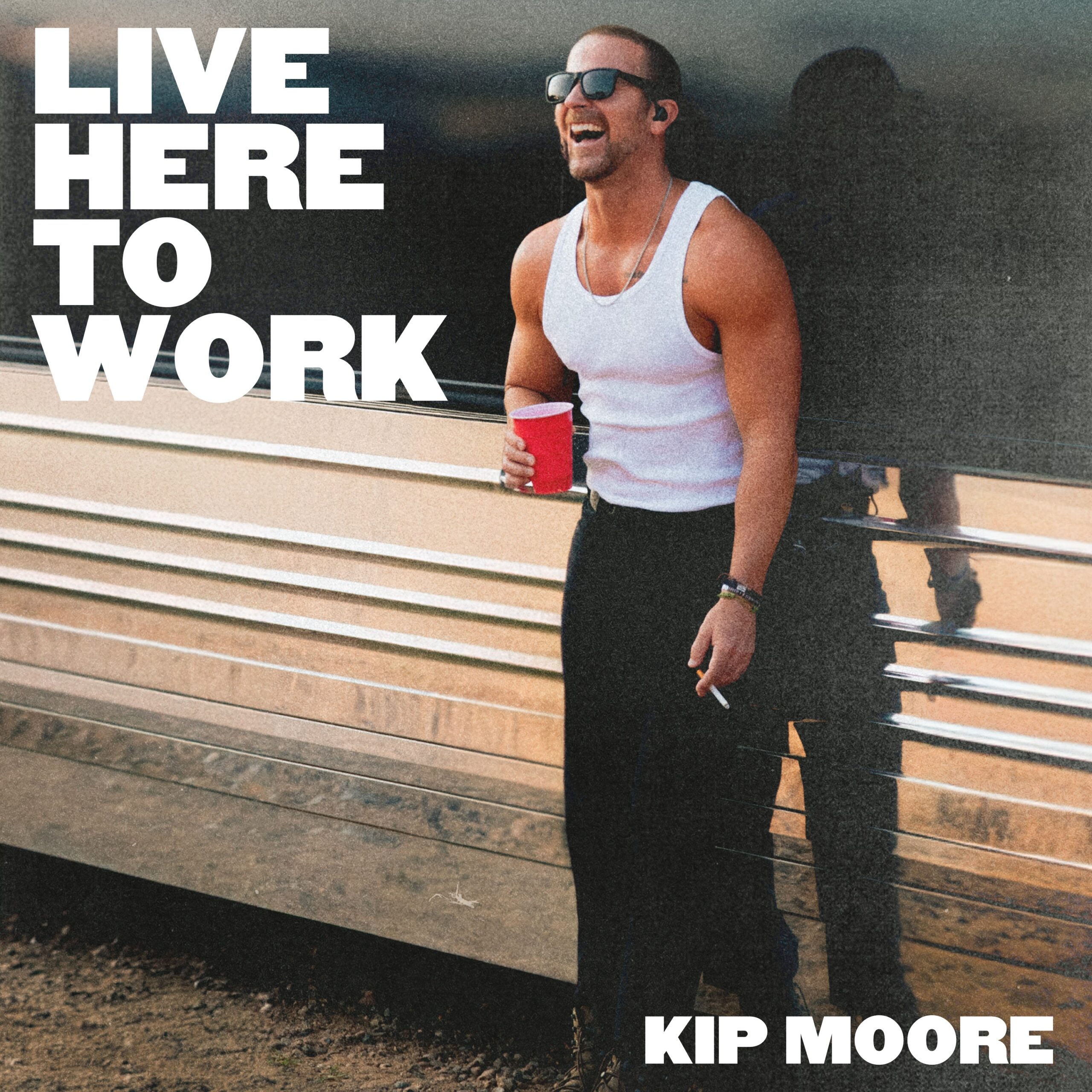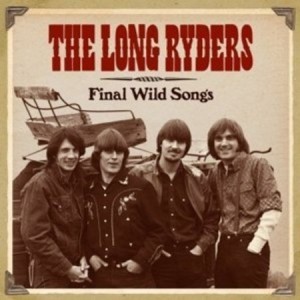 Tra la miriade di ristampe, più o meno utili, più o meno preziose, un posto di rilievo lo occupa il box dedicato ad una band culto per quanto riguarda le commistioni tra rock e radici: The Long Ryders. Il quartetto formato da Sid Griffin, Stephen McCarthy, Greg Sowders e Tom Stevens ha rappresentato l’anello di congiunzione tra il più poderoso e vitale rock’n’roll e le radici folk e country, tra i Byrds e Tom Petty, due riferimenti basilari, in anni (gli ’80) in cui in auge c’erano l’elettro pop britannico e la dance più spinta. Assieme ai Los Lobos, ai Blasters dei fratelli Alvin, ai Dream Syndicate e a pochi altri riuscirono a riportare le ‘roots’ in primo piano dopo la sbornia punk della decade precedente. “Final Wild Songs” (piccolo box di 4 cd) ci ripropone questa splendida e purtroppo breve stagione musicale con tanto materiale inedito e un travolgente concerto che conferma tutta la inesauribile verve di una band che ha fatto scuola pur rimanendo confinata ad un seguito ‘di nicchia’.
Tra la miriade di ristampe, più o meno utili, più o meno preziose, un posto di rilievo lo occupa il box dedicato ad una band culto per quanto riguarda le commistioni tra rock e radici: The Long Ryders. Il quartetto formato da Sid Griffin, Stephen McCarthy, Greg Sowders e Tom Stevens ha rappresentato l’anello di congiunzione tra il più poderoso e vitale rock’n’roll e le radici folk e country, tra i Byrds e Tom Petty, due riferimenti basilari, in anni (gli ’80) in cui in auge c’erano l’elettro pop britannico e la dance più spinta. Assieme ai Los Lobos, ai Blasters dei fratelli Alvin, ai Dream Syndicate e a pochi altri riuscirono a riportare le ‘roots’ in primo piano dopo la sbornia punk della decade precedente. “Final Wild Songs” (piccolo box di 4 cd) ci ripropone questa splendida e purtroppo breve stagione musicale con tanto materiale inedito e un travolgente concerto che conferma tutta la inesauribile verve di una band che ha fatto scuola pur rimanendo confinata ad un seguito ‘di nicchia’.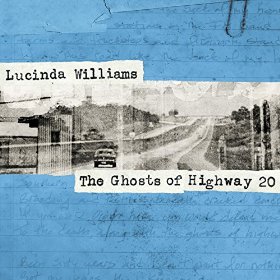
Musica e poesia, il mito americano del viaggio e le profonde riflessioni ed introspezioni tipiche dei migliori ‘storytellers’ sono le peculiarità della proposta di Lucinda Williams, cantante ed autrice di Lake Charles, Louisiana che prosegue una carriera straordinaria con un nuovo episodio, doppio ancora una volta dopo “Down Where The Spirit Meets The Bone”, tra le sue più intense proposte discografiche. “The Ghosts Of Highway 20” è più intimista e meditato, incentrato sul viaggio, metafisico o reale che sia, lungo i percorsi del deep south, con numerosi riferimenti autobiografici che lo rendono ulteriormente intriso di forza espressiva. Con la sua voce strascicata e sofferta, Lucinda mostra ancora una volta di essere tra le migliori autrici contemporanee negli States e la produzione a tre, con la stessa Williams, Greg Leisz e Tom Overby, risulta limpida e impeccabile. Amore, morte, sofferenza, nostalgia, maliconia e rimpianto scorrono attraverso le quattordici canzoni dell’album lasciando dietro una scia di emozioni che si ricorderanno a lungo. Arrivano da Portland, Oregon ma la loro musica è chiaramente ispirata a New Orleans in un bollente mix di blues, soul, funk e rock. I Roseland Hunters debuttano con “This Time”, disco prodotto dal Los Lobos Steve Berlin e lo fanno con la forza e la consapevolezza di una band i cui membri sono ‘on stage’ da anni. A guidare i Roseland Hunters c’è il cantante, autore e chitarrista Michael Quinby, con la potente cantante di colore Larhonda Steel, il bassista Damian Erskine, il batterista Reinhardt Melz, il percussionista Caton Lyles e il tastierista Alex Milstedt a completare una line-up che ha gli stessi profumi, gli stessi colori e la stessa grinta dei vecchi Little Feat o dei Neville Brothers, per citare i primi due ispiratori che vengono in mente.
 Caleidoscopici e propositivi, i Roseland Hunters si pongono come una delle migliori band della west coast nel loro genere. Clarence Bucaro è un musicista nato in Ohio ma attualmente residente a Brooklyn, New York dopo una vita ‘bohemienne’ e un po’ randagia che lo ha portato a vivere a New Orleans e Los Angeles per alcuni anni. Il suo stile non è facilmente classificabile, ha nel suo dna la canzone d’autore influenzata via via dalla tradizione folk, dagli stilemi country e dalle fascinazioni soul e pop in un insieme piacevolissimo e non banale. “Like The 1st Time”, prodotto dal veterano Tom Schick (ha lavorato con Ryan Adams, Norah Jones e Wilco tra gli altri) è un disco morbido e godibile, vario e pieno di riferimenti, da centellinare nelle vostre serate più tranquille. Dai suoni soul e gospel di “Let The Mystery Be” con i Blind Boys Of Alabama come ospiti alla cristallina melodia ‘folkie’ di Somewhere In The Middle”, dalla significativa title-track all’accorata “Can’t Rush The Road” fino all’amore per Van Morrison sviscerato in “Alone In Love”, Clarence Bucaro dà sempre l’impressione di trovarsi a proprio agio e gioca con sapienza ed introspezione le proprie carte. Di tutt’altro tenore sono invece i Western Star, travolgente rock’n’roll band che attualmente ha base in Texas ma che si differenzia da molti suoi conterranei proponendo un sound selvaggio e chitarristico, con sferragliate punk e qualche ricordo country che fa comunque fatica ad emergere tra i decibel di questo “Fireball”, album prodotto dal Old 97, Ken Bethea.
Caleidoscopici e propositivi, i Roseland Hunters si pongono come una delle migliori band della west coast nel loro genere. Clarence Bucaro è un musicista nato in Ohio ma attualmente residente a Brooklyn, New York dopo una vita ‘bohemienne’ e un po’ randagia che lo ha portato a vivere a New Orleans e Los Angeles per alcuni anni. Il suo stile non è facilmente classificabile, ha nel suo dna la canzone d’autore influenzata via via dalla tradizione folk, dagli stilemi country e dalle fascinazioni soul e pop in un insieme piacevolissimo e non banale. “Like The 1st Time”, prodotto dal veterano Tom Schick (ha lavorato con Ryan Adams, Norah Jones e Wilco tra gli altri) è un disco morbido e godibile, vario e pieno di riferimenti, da centellinare nelle vostre serate più tranquille. Dai suoni soul e gospel di “Let The Mystery Be” con i Blind Boys Of Alabama come ospiti alla cristallina melodia ‘folkie’ di Somewhere In The Middle”, dalla significativa title-track all’accorata “Can’t Rush The Road” fino all’amore per Van Morrison sviscerato in “Alone In Love”, Clarence Bucaro dà sempre l’impressione di trovarsi a proprio agio e gioca con sapienza ed introspezione le proprie carte. Di tutt’altro tenore sono invece i Western Star, travolgente rock’n’roll band che attualmente ha base in Texas ma che si differenzia da molti suoi conterranei proponendo un sound selvaggio e chitarristico, con sferragliate punk e qualche ricordo country che fa comunque fatica ad emergere tra i decibel di questo “Fireball”, album prodotto dal Old 97, Ken Bethea.
 La band vede i fratelli Max e Nicholas Jeffers guidare un quartetto granitico e poderoso di cui fanno parte anche Justin Myers e Bob Shade con un suono da tipica ‘barroom band’ che non prende prigionieri e consuma ogni goccia di sudore con grinta e passione. Dodici ‘numeri’ fortemente rock che si stemperano solo nella comunque sofferta “Aeorangel” che dà un po’ di respiro e ricorda certe cose degli Aerosmith, in “Stars & Cards” e nella conclusiva “Oracle”. For rock fans only.(Remo Ricaldone)
La band vede i fratelli Max e Nicholas Jeffers guidare un quartetto granitico e poderoso di cui fanno parte anche Justin Myers e Bob Shade con un suono da tipica ‘barroom band’ che non prende prigionieri e consuma ogni goccia di sudore con grinta e passione. Dodici ‘numeri’ fortemente rock che si stemperano solo nella comunque sofferta “Aeorangel” che dà un po’ di respiro e ricorda certe cose degli Aerosmith, in “Stars & Cards” e nella conclusiva “Oracle”. For rock fans only.(Remo Ricaldone)