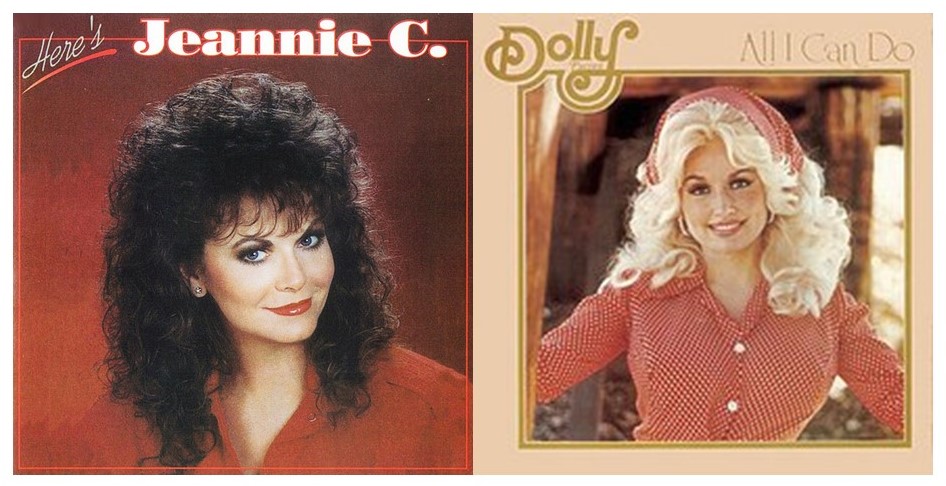Jefferson Ross è un personaggio dalle molte sfaccettature, capace di raccontare il sud nei suoi aspetti più veri e vibranti attraverso l’amore per la musica, per la letteratura e per i personaggi che l’hanno caratterizzato e l’hanno vissuto intensamente. Il rapporto profondo con la propria terra, con uno spirito religioso che non ha nulla a che vedere con la visione reazionaria che contraddistingue molti ambienti ma che abbraccia i mille volti di un’America alle prese con le contraddizioni e le controversie dei nostri giorni è qui narrato con efficacia. Già con il precedente bellissimo disco intitolato “Southern Currency”, il musicista della Georgia aveva colto nel segno con un pregnante viaggio negli Stati del profondo sud impreziosito da melodie veramente affascinanti e ora prosegue il suo cammino introspettivo nelle quattordici canzoni (per una durata poco inferiore all’ora) che compongono “Backstage Balladeer”, disco scritto, suonato, registrato e mixato dallo stesso Jefferson Ross senza aiuto esterno alcuno. Un album che colpisce direttamente al cuore per una sensibilità intrisa come detto di religiosità (il gospel di “Lion In Zion” e la chiusura affidata a “House Of The Lord” in primis) che fa emergere umanità, empatia e senso di condivisione, di gusto per la melodia sempre presente in ogni brano e di amore e rispetto per i grandi della letteratura ‘sudista’, da Mark Twain a Fannery O’Connor le cui citazioni fanno bella mostra nelle note di copertina. Le molteplici ed eccellenti doti di strumentista di Jefferson Ross non fanno che rendere godibili e variegate le canzoni che scorrono limpide e naturali passando dai divertimenti tex-mex di “One Taco At A Time” che ricordano per esempio i grandi Texas Tornados a pure atmosfere ‘byrdsiane’ come nell’iniziale “Crooked Lines”. Per tutto il disco è comunque palpabile la passione che Jefferson Ross infonde nella ricerca di stimoli country (“Let’s Start A Cult”, la sinuosa “Jerry Lee Lewis” con una notevole interpretazione vocale e la title-track estremamente significativa), folk (“Serpent” segnata da un bel banjo e da una melodia impeccabile, la cristallina “Mary Magdalene”) e umori sixties (“I Believe What I Think I Know” mi ricorda molto i Dillards elettrici degli anni a cavallo tra sessanta e settanta). Un disco di grande efficacia che viaggia nei tempi e nei luoghi più cari a Jefferson Ross e che ce lo presenta come uno dei più validi esponenti della scena indipendente americana.
Remo Ricaldone